 12 settembre 2008 – Era stata una sorpresa per me, al termine di una Messa, nella piccola Cappella della residenza di Costagrande, sulle colline di Verona, sentir dire da don Antonio Mazzi ai suoi Educatori: «Fate tesoro delle vostre fragilità!». La sua voce era dolce e accorata, quasi un’ingiunzione del cielo che calasse su di noi, decreto da rispettare. O forse no, era esortazione al coraggio di sé. Negli incontri di Costagrande è sempre così: le giornate di riflessione e di confronto si traducono in occasioni di crescita morale, grazie alle ‘parole’ che don Antonio lascia in eredità, su cui meditare per anni. Ci vorrà molto tempo per recuperarle tutte e dare ragione dei moniti come delle affettuose illuminazioni ricevute in dono.
12 settembre 2008 – Era stata una sorpresa per me, al termine di una Messa, nella piccola Cappella della residenza di Costagrande, sulle colline di Verona, sentir dire da don Antonio Mazzi ai suoi Educatori: «Fate tesoro delle vostre fragilità!». La sua voce era dolce e accorata, quasi un’ingiunzione del cielo che calasse su di noi, decreto da rispettare. O forse no, era esortazione al coraggio di sé. Negli incontri di Costagrande è sempre così: le giornate di riflessione e di confronto si traducono in occasioni di crescita morale, grazie alle ‘parole’ che don Antonio lascia in eredità, su cui meditare per anni. Ci vorrà molto tempo per recuperarle tutte e dare ragione dei moniti come delle affettuose illuminazioni ricevute in dono.
Fragilità non è debolezza. Non è difetto di moralità né di autorevolezza. Non è ‘caduta’ né sconfitta del nucleo vitale della coscienza. Un grande analista junghiano ha scritto: «Crescere, cioè discendere». E venire a contatto con la parte tenera e friabile dell’anima, quella che sembra franare all’improvviso per la commozione, per un pianto apparentemente immotivato, è scoperta di sé, stupore morale. La superficie compatta dell’Io si rivela discreta, discontinua, permeabile alle incursioni della vita. Fessure e ferite sembrano insinuarsi nel compatto scorrere dei giorni, generando impermanenza e frastornando il cuore.
Si sente il bisogno di dire: «Cosa è accaduto? E’ accaduto a me? Credevo di essere al sicuro, al riparo dalla pioggia come dalle altre intemperie». Eppure, piove. Piccoli colpi insistenti picchiano sul petto fino a farlo indolenzire. A volte, arrivano brusche sferzate in basso, là dove più sicure sembravano le difese. Che poi accada in pubblico, proprio davanti alle persone dalle quali non vorremmo mai farci vedere commossi o addirittura piangere, è causa di vergogna e turbamento. I recinti dell’anima sembrano steccati non idonei a sostenere i transiti disordinati della vita. Da fuori viene, infatti, alto il frastuono della vita stessa. A nulla serve approntare trincee. Il vallo che sempre oppose valide resistenze al nemico ha ceduto. Terrapieno e palizzata non bastano certo a fermare l’onda che preme ai confini. Irrompe nell’anima un significato inaudito o forse è il senso che sempre ebbero le cose: è nuovo il sentore di luce che sferza la radura. Sciabolate di luce invadono ogni passaggio. L’anima è inondata da un cotal nuovo che quasi arretra stordita.
Non ci conoscevamo fragili. Inizialmente, opponevamo altre certezze alla percezione incrinata dal dubbio. Non volevamo ammettere di essere esposti al vento benefico della vita che promana dalle esistenze altre, dal vario e altalenante respiro del comune. Forse è tutto qui: non accettiamo che un comune sentimento, che una comunissima emozione ci prenda al punto da farci vacillare. Non vorremmo mai piangere. Non vogliamo che gli altri vedano le lacrime scorrere sul viso. Vorremmo trattenere almeno quelle, se non proprio nascondere gli occhi lucidi. Dove trovare uno schermo all’empito del cuore, al travaso dell’anima, al singhiozzo smorzato dai denti stretti? Noi allora vorremmo che qualcuno ci abbracciasse per essere quello schermo non trovato e il lenzuolo che assorbe il pianto e le braccia che accolgono lo smarrimento. Vorremmo che qualcuno ci confortasse per essere nati. Che ci desse ragione del nostro pianto, ma delicatamente, senza spiegare proprio tutto… Vorremmo essere sfiorati dalla carezza della voce amica, che non fa male al cuore. Ma, soprattutto, non vorremmo cadere sotto lo sguardo indagatore dei vicini e dei curiosi che vorrebbero entrare nel recinto della nostra anima, e lo fanno, e si aggirano nelle stanze e scrutano ogni piega del nostro viso, e siamo nudi lì davanti ai giudici, colpevoli di noi stessi.
Era stata una sorpresa per me sentir dire da don Antonio ai suoi Educatori: «Fate tesoro delle vostre fragilità!». La sorpresa derivava dal fatto che se ne dovesse fare tesoro, che la propria fragilità, che le proprie fragilità dovessero essere conservate non disperse, custodite non dissipate, valorizzate non taciute né nascoste.
Io lo sapevo bene, perché avevo già osservato – e per decenni! – la mia feroce timidezza, soprattutto con le donne, ed ero consapevole delle limitazioni che derivavano dall’esser timido. Da bambino, arrossivo davanti a tutti, anche ai maschi: bastava che qualcuno mi guardasse. Non riuscivo a sopportare a lungo lo sguardo di qualcuno su di me. Per oltre cinquant’anni ho combattuto la mia timidezza, naturalmente, senza sconfiggerla. Sono timido. Passando dal rifiuto all’accettazione del mio sentire schivo, ho imparato con il tempo a governare i miei sentimenti: l’esperienza del dolore è la via.
Al di là delle teorie, che si sono accavallate e confuse negli ultimi due secoli, è utile distinguere tra ciò che muta in noi e ciò che cresce e si sviluppa senza mai rovesciarsi nel contrario… La forza del carattere, la sua natura risiede nel suo divenire ciò che ognuno di noi ha da essere. La crescita è un saggio di come si diventa ciò che si è. Si tratta di sconfiggere i pregiudizi più radicati, relativamente alla natura umana, alla realtà del carattere personale… Del nostro daimon, il senso comune è sempre portato a pensare che debba cambiare, che si possa divenire altro rispetto a ciò che si è. C’è chi si ostina per tutta la vita a tormentare un partner che non cambia: le cose sarebbero perfette se l’altro cambiasse, per diventare finalmente ciò che noi vorremmo che fosse! Dovrebbe, poi, colpirci l’affermazione di Galimberti, secondo il quale bisognerebbe amare le persone così come sono! A ben guardare, al termine di tutte le personali riflessioni sull’amore, acquisita una maturità affettiva, essendo divenuti capaci di sentimenti adulti, ci ritroviamo a pensare che amare le persone così come sono è forse l’unica cosa che si possa fare. Diversamente, ci si impegnerà in attività che esulano dall’amore o che introducono nell’esperienza amorosa le pretese eccessive che tormentano e lo ‘uccidono’.
Scoprire le proprie fragilità, allora, è
- riconoscere l’esistenza di uno strato profondo del cuore, che occorre attivare, lasciando che resti esposto al contatto con il mondo;
- accettare quel contatto, senza erigere difese che impediscano al cuore di sentire quello che si agita nel cuore altrui;
- accogliere nella propria mente i mondi possibili che si dischiudono tutte le volte che si sperimenta l’irruzione di significati altri nel recinto dell’anima;
- patire la distanza, graduandola nel rapporto con l’altro, in quella “giusta distanza” che impedisce all’amore di travolgere e all’indifferenza di raggelare;
- esprimere coraggiosamente il proprio sentire, senza rinunciare al dolore, che è nutrimento dell’anima, via obbligata che conduce al governo di sé.
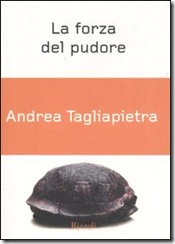 Per quanto mi riguarda, fare tesoro delle proprie fragilità significa, ad esempio, riconoscere la timidezza come componente ineliminabile del mio daimon: il mio carattere porta il segno di questo ‘sentire’, che si è fatto con il tempo vita schiva…Da questa mia ‘natura’ consegue una serie di risposte, di modi di rispondere alle sollecitazioni esterne che hanno condizionato tutta la mia vita, rendendola quello che è. Grazie al riconoscimento dei tesori che si nascondono nella vita schiva, ho scoperto in una mia fragilità le virtù di quel sentire, che vanno dalla virtù dell’innocenza alla virtù introspettiva, alla virtù del congedo. Su questa «elegia delle cose esitanti» si è soffermato nella primavera del 2007 Duccio Demetrio con un libro bellissimo sull’argomento, intitolato: La vita schiva. Il sentimento e le virtù della timidezza: un’autentica miniera di idee, oltre che di suggerimenti per l’azione e per la vita contemplativa. Il nostro tempo ha eretto a modello di comportamento il suo ‘contrario’, quella spudoratezza che abolisce ogni confine, rinunciando a difendere lo spazio interno dagli assalti dell’esterno: essa si spinge addirittura fino al punto di aprire per intero lo spazio interiore agli sguardi indiscreti del mondo, abolendo l’azione del pudore, che è il motore della nostra libertà.
Per quanto mi riguarda, fare tesoro delle proprie fragilità significa, ad esempio, riconoscere la timidezza come componente ineliminabile del mio daimon: il mio carattere porta il segno di questo ‘sentire’, che si è fatto con il tempo vita schiva…Da questa mia ‘natura’ consegue una serie di risposte, di modi di rispondere alle sollecitazioni esterne che hanno condizionato tutta la mia vita, rendendola quello che è. Grazie al riconoscimento dei tesori che si nascondono nella vita schiva, ho scoperto in una mia fragilità le virtù di quel sentire, che vanno dalla virtù dell’innocenza alla virtù introspettiva, alla virtù del congedo. Su questa «elegia delle cose esitanti» si è soffermato nella primavera del 2007 Duccio Demetrio con un libro bellissimo sull’argomento, intitolato: La vita schiva. Il sentimento e le virtù della timidezza: un’autentica miniera di idee, oltre che di suggerimenti per l’azione e per la vita contemplativa. Il nostro tempo ha eretto a modello di comportamento il suo ‘contrario’, quella spudoratezza che abolisce ogni confine, rinunciando a difendere lo spazio interno dagli assalti dell’esterno: essa si spinge addirittura fino al punto di aprire per intero lo spazio interiore agli sguardi indiscreti del mondo, abolendo l’azione del pudore, che è il motore della nostra libertà.
* * *
Nella primavera del 2002, riassumevo in un piccolo saggio etico-politico quelli che pomposamente chiamavo ‘fondamenti del lavoro sociale’.
VII. ETHOS ANTHROPOI DAIMON
[ La relazione con il ragazzo e la sua famiglia è definita etica. La relazione etica – e non psicologica – allude ad un legame originario, a un fondo comune che è dato dalla comune appartenenza di genere.
Essere parte del genere umano richiede un’etica originaria, un quadro di regole, cioè, che trovi il suo fondamento nell’ethos, nel costume collettivo. Ma ethos, come è detto nel titolo del paragrafo, rinvia a daimon: un filologo ha proposto di tradurre quel frammento del filosofo greco Eraclito come se ethos avesse in comune con daimon una radice in quello che di proprio, di soggettivo c’è in ognuno di noi.
Il mio ethos è il mio daimon. La mia moralità trova la sua radice originaria nel mio modo di essere. Incontrerà l’ethos dell’altro nel suo daimon. Il demone è quello che ci spinge ad agire. ]
Il rapporto che si istituisce sul campo con il ragazzo e con la sua famiglia si definirà sempre più nell’ambito di una cultura della RELAZIONE ETICA. L’azione educativa è anche etica, in quanto mira ad instaurare un insieme di comportamenti finalizzati ad un valore. Ciò che si tratterà di fondare è la possibilità di un ethos comune.
L’azione di volontariato incontra il suo fondamento in un’ETICA ORIGINARIA, nel riconoscimento che Eθoςanθρωποidaimon, che significa: «Demone a ciascuno è il suo modo di essere». Ethos, più che il comportamento collettivo o il costume, come abitualmente si dice, designa il modo di essere. Designa il modo di essere di ciascuno inteso nella sua irripetibile unicità: il modo di essere che è suo, che gli è proprio. L’etimo stesso di ethos contiene una radice che allude al suo, al sé. L’ethos pertiene all’esistente umano nella sua unicità. Indica ciò che è proprio dell’unico. Per questo esso corrisponde al daimon.

