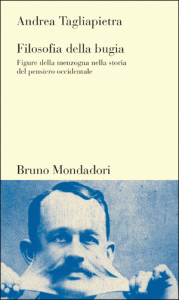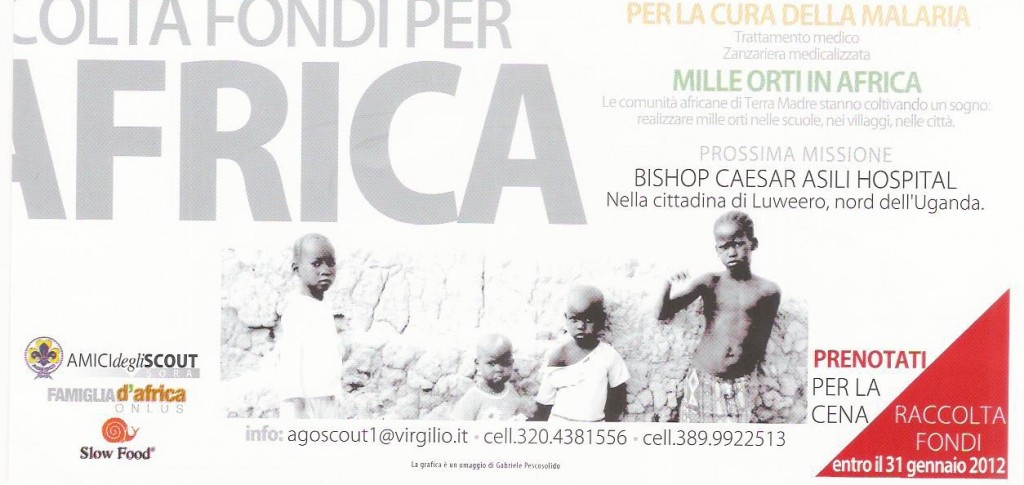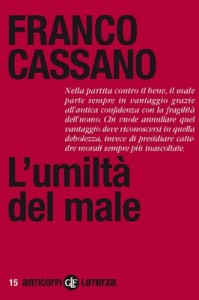CLAUDE OLIEVENSTEIN, Tossicodipendenza e angoscia di morte – L’Indice 1993, n.8
“Tu non toccherai il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male…” Adamo ed Eva furono così cacciati dal paradiso. La prima droga era nata e, con essa, la nudità e la consapevolezza da parte dell’uomo di essere mortale.
Tutte le tossicomanie si rispecchiano in questa parabola della Genesi. Non si parla forse di paradisi artificiali? La nudità rimanda al sesso così come la conoscenza del Bene e del Male. Soprattutto però l’uomo, cacciato dal paradiso a causa, o grazie, alla droga, si scopre mortale, e qui si colloca la frattura tra la parola e la realtà: Dio aveva promesso di punire Adamo ed Eva con la morte immediata. Ma l’esito fu l’apprendimento, nel dolore e nel sangue, di quell’intervallo che si potrebbe definire vi-ta, tra l’opzione assoluta della morte e la morte stessa.
Ciò che il bambino non sa e che scopre a poco a poco quando, cacciato dal paradiso uterino, viene costretto a nutrirsi al seno, è la percezione di questa frattura tra il bisogno e la soddisfazione. Basta ascoltare il pianto di un neonato per capire che la questione è seria e che, al di là della fame, si sta confrontando con ben altra cosa. Si può dire che quest’altra cosa, ancora oggi così misteriosa ai nostri occhi, è la paura di morire, la fine del paradiso nella morte e che forse, un giorno non sarà più possibile ritrovare né la mela né il seno.
Il futuro tossicomane è l’esito di un rapporto complesso in cui giocano l’intensità, la velocità e l’atmosfera; egli giungerà a temere di non poter più essere riempito e sempre reclamerà la sua mela, qualunque essa sia.
Questo vissuto della mancanza-ripetizione e della ripetizione della mancanza, che è proprio del tossicomane, è in sé banale ma, per ragioni che qui cercheremo di chiarire, acquisisce una valenza diversa a seconda dell’intensità, della velocità e dell’atmosfera in cui si svolgono quei piccoli drammi che si fanno enormi a misura delle carenze identificatorie e dell’immaginario.
Precoci carenze d’identificazione e dell’immaginario nascono in quello che abbiamo chiamato lo ‘stadio dello specchio infranto’. Vale la pena ricordare che per noi il futuro tossicomane si colloca tra lo psicotico, che rimane ad uno stadio fusionale e mai raggiungerà lo stadio dello specchio, e i nevrotici, o normali, che realizzeranno lo stadio dello specchio, nel quale si ritroveranno “io”, soggetto. In questa posizione intermedia il futuro tossicomane smarrisce la sua identità nell’attimo in cui la percepisce. Questo choc, reale o simbolico, è unico per natura e intensità. Perdendo un’identità che non ha mai avuto, ma che ha intravisto, egli si avvicina vertiginosamente e a velocità immensa alla morte. È “mezzo morto”. È e non è, come chi sta aggrappato al bordo di un baratro. È una posizione letteralmente insostenibile e, infatti, non sarà possibile mantenerla. Tutta la sua vita sarà tesa all’annullamento di questa mancanza originaria attraverso una ricerca spasmodica di supporti i-dentificatori che si riveleranno, uno dopo l’altro, frustranti.
Diversamente da tutti gli altri, egli è il solo uomo che dall’inizio era riuscito a scorgere la distruzione dell’identità, ciò che c’è di più prossimo alla morte. Si capirà evidentemente più tardi che è della mancanza della mancanza che il futuro tossicomane avrà paura, anche quando l’oggetto droga non gli darà più piacere, perché quando non è più nella mancanza oggettivata rischia di ritrovarsi in questa incredibile frattura. Poiché il bambino non è solo, quest’angoscia si trasforma in un’immensa richiesta dai genitori. Essi non comprendono o non sopportano una simile e smisurata richiesta e la rifiuteranno con un bacio anodino. Il bambino a sua volta reagirà a queste frustrazioni, tanto più insopporta-bili in quanto incomprensibili, con una spirale ascendente. Questa incomprensione, questi riferimenti impossibili, rimandano alla nozione di un debito originario che andrà a sommarsi al dramma già vissuto, rinviando il soggetto ad un’assenza mortifera.
Se riprendiamo ciò che abbiamo scritto altrove sull’infanzia del tossicomane, a partire da questo stadio iniziale, avremo modo di vedere un po’ più chiaramente il rapporto accelerato con l’angoscia di morte, rapporto la cui intensità è così importante che, attivato dal suo continuo lavorio rivolto alla riscoperta dell’identità, fa sì che il bambino non possa giungere a un immaginario positivo in grado di confermare, almeno in parte, la vacuità dell’esserci.
Nella sua infanzia, dopo lo stadio dello specchio infranto, il bambino vivrà quello della dismisura. La dismisura comincia come diniego; essa è indispensabile alla negazione: meno agisce e più il bambino si troverà in una spirale ascendente in cui, con ogni mezzo, andrà alla ricerca della non-morte. E’ il principio della scalata che ritroveremo nel rapporto con l’oggetto-droga. Il vissuto del bambino è, linguisticamente, banale; banale anche in termini di causalità. Si tratta di un fenomeno riscon-trabile in molti bambini e adolescenti ad alto rischio, ma ciò che è analogamente banale in termini di causalità è, ripetiamolo, l’intensità, la cinetica, l’atmosfera.
Il bambino è costretto in una coazione ludica. Vi è costretto perché per evitare il caos arcaico, deve allucinare il reale. Ricordiamo che il reale è il reale, non il vero. Il bambino, futuro tossicomane, lo sa in quanto lo vive. Egli vive la negazione di sé che si è autoattribuito. Allucinare il reale nella coazione ludica gli consente di differire il confronto con l’esperire, confronto che emerge nelle angosce notturne, abbozzo di ciò che vivrà in età adulta: le insonnie. Le angosce notturne sono un sintomo banale, il loro prolungamento – gli incubi che vive – appartiene allo stadio della dismisura.
Le carenze d’identificazione e immaginarie lasciano spazio alla vittimizzazione del bambino; è questa vittimizzazione che, attraverso il gioco della provocazione-repressione, lo trasforma in capro espiatorio, in ciò che ho definito “l’idiota di famiglia”. Possiamo dire che in questo stadio si colloca il primo tentativo di suicidio: “sto così male; i miei genitori non mi amano o mi amano troppo, in ogni caso non sono nel giusto, non merita di vivere”. La morte è al tempo stesso sollecitata e temuta. In alcuni si verificherà una vera progressione nella relazione fascinante con il suicidio che, più tardi, ritroveremo nel tossicomane. La ripetizione dei tentativi di suicidio è un modo per addomesticare l’angoscia di morte. Dopo il suicidio non è possibile andare oltre, non ci sarà più angoscia di morte.
Nella spirale ascendente verso la tossicomania il soggetto incontra il piacere. Il piacere è importante, essenziale, in quanto permette, nel godimento, di annullare ogni mancanza e pertanto la più importante: quella nata dalla rottura. La masturbazione (che in sé è banale) assume qui tutto il suo valore. Essa è strumento di verifica, fosse anche solo momentanea, di una possibile identità. Si ripete e si prolunga al di là dei rapporti con un/una partner. Il ricordo del godimento provato s’inscrive nella memoria del soggetto in quanto certezza di un futuro possibile, ma è insufficiente per permettere al bambino di affrontare il reale, per quelli che non sono in grado di individuare dei supporti identificatori compensativi. Significherà ricercare il piacere nell’androginia.
L’androginia non è omosessualità; è ricerca, nella bifaccialità, di una completezza che il soggetto non possiede. Che non ritroverà né nei partner del suo sesso né in quelli dell’altro. La mancanza è in lui, una mancanza terribile: è negazione dell’identità, dell’immaginarlo, un vuoto dunque, vertigine profonda che, nella spirale di cui abbiamo parlato, lo trascina irresistibilmente verso la morte.
Questa spirale non è specifica del tossicomane, la si ritrova in altri soggetti ad alto rischio e specialmente nei suicidiari o nei perversi. Questi ultimi troveranno nel passaggio all’atto ripetuto una modalità di esistenza che consente loro di sfuggire all’angoscia di morte, ma la coazione a ripetere del perverso non è feconda. Questa non fertilità non è sufficiente, non agisce per il futuro tossicomane.
E’ l’oggetto droga che, una volta incontrato, diventa operativo e fecondo. C’è una precisa specificità nell’incontro del soggetto con l’oggetto droga che definiremo ‘fatto tossicomanico’ in quanto si tratta di un evento piuttosto che di una personalità o di una struttura specifica. Il fatto tossicomanico si realizza negli effetti del prodotto e nella loro assenza. E’ il rapporto duale a diventare supporto identificatorio, non questa o quell’altra immagine parentale o sociale. Il rapporto duale creato dall’immaginario. E’ fondamentale che questo immaginario della droga sia poco o per nulla culturalizzato e non proceda come discorso strutturato o costruzione fantastica organizzata; è quasi impressionismo, magma parcellizzato sospeso in un’atmosfera unica fatta di calore, ingenuità e arcaismo.
All’inizio questo incontro è soddisfacente a due livelli, quello del piacere e quello dell’identità ricostruita. E’ evidente che quanto sto dicendo rappresenta una condizione idilliaca ed esterna, ma ogni tossicomane, in base alla profondità del trauma originario, vive questa fase che si definisce ‘luna di miele’, capace di allontanare/annullare l’angoscia di morte.
Ma non è cosi per sempre: la sostanza svolge il suo ruolo in modo sempre meno soddisfacente e lo statuto ontologico del soggetto rimane immodificato; il fatto tossicomanico, per essere operativo, ha bisogno di modificarsi. Si entra nel ciclo della dipendenza e della mancanza. Diversamente dall’animale, la mancanza e la dipendenza dell’uomo sono fenomeni psichici attivi ricercati dal soggetto in quanto organizzazione spazio-temporale che gli consente di non ritrovarsi in una condizione di mancanza della mancanza.
In effetti, ciò che è insopportabile, malgrado questa esperienza inconfessabile, sarà il ritrovarsi del soggetto al punto di partenza. Il tempo vissuto diventerà tanto più insopportabile quanto più nella sua peripezia egli sarà arrivato in prossimità dell’estasi e di una certa immortalità. Nella mancanza della mancanza egli non è altro che il bambino il cui specchio si frantuma, non può essere che sofferenza e angoscia di morte. Egli organizza allora la sua esistenza per evitare tutto questo e dunque utilizza la mancanza del prodotto come un’arma che gli consente di conoscere i limiti di un tempo vissuto in modo tossicomanico. Tutto ciò è motivo di dolore che, però, in questo stadio di verifica, gli consente di vivere.
Tuttavia il prezzo da pagare diventa troppo alto. Per ragioni sociali, libidinali, familiari il tossicomane cercherà di fermarsi. Entrerà in una nuova fase che potremmo definire la sofferenza del soggetto disintossicato.
In questo stadio il soggetto vive una morte differita. Non può più utilizzare il costante bisogno di ripetizione, né la reiterazione del bisogno di cui conosce gli esiti. Il tempo vissuto si dilata incredibilmente, l’umore diventa depresso, melanconico. Ed è la notte che si fa interminabile in una smisuratezza assoluta. Se non utilizza altri ammortizzatori chimici o istituzionali il soggetto è confrontato continuamente con la morte. Certo, l’angoscia di morte può essere manipolata e rovesciata in un “A che serve vivere? A cosa serve tutto questo? Soffro troppo per sopportarlo”. In realtà ciò che si disvela è l’impossibilità di essere, subito e ora. Il terzo rapporto duale si stabilisce tra l’uomo e la sofferenza. Una coppia che è parte intrinseca al fatto tossicomanico. Non è il prodotto o, meglio, è solo parzialmente il prodotto di uno di questi fattori di rischio che costellano la sua infanzia e la sua adolescenza. È l’ultimo anello di una catena che unisce la frattura iniziale a quella finale, grazie al prodotto e per mezzo di esso.
In quest’ultima fase il soggetto ha tre possibili opzioni: la ricaduta nel tentativo di non ritrovarsi nella mancanza della mancanza, il compro-messo ortopedico che lo costringe ad accettare, anche se menomato, il reale come compagno oppure la morte.
Non lo si ripeterà mai abbastanza: è il tossicomane guarito che si suicida. Egli si trova di fatto a dover gestire questa difficile contraddizione della morte che si è sostituita a quel buon oggetto transizionale che è la droga (la morte diventa così oggetto buono), e l’angoscia di morte, che paradossalmente è sorgente di vita, prova che malgrado tutto lui ha un’identità, che ha qualcosa da proteggere, sicuramente molto fragile, compensazione precaria data da un immaginario positivo arcaico ma che gli consente di esistere così come la mancanza glielo ha permesso.
Il problema che si pone al terapeuta è quello di trasformare la morte-oggetto buono in morte-oggetto cattivo. Tutto però gli è contrario: la stessa storia familiare, dove non è raro che il bambino sostituisca un fratello morto, o sia nato indesiderato, o che il suo sesso non sia stato quello desiderato; più tardi l’insuccesso o l’inadattamento scolastico e, ancora, una sessualità che gli lascia il gusto amaro di qualcosa che può essere raggiunto ma che non è mai; infine l’incontro con la droga in cui ha potuto essere vicinissimo all’immortalità, folgorazione effimera che gli sfugge in una spirale discendente in cui il piacere cede il posto alla mancanza e la mancanza stessa si rivela inadeguata. È quando la dipendenza non è più per il soggetto una modalità di essere al mondo che lo proteggeva dalle sue angosce più profonde che si apre la breccia per l’angoscia di morte. Essa può definirsi angoscia di essere al mondo con l’apertura originaria ma all’oscuro del prezzo da pagare per un tale debito.
Non esiste angoscia di morte senza un profondo senso di colpa. Nel tossicomane questo senso di colpa è al tempo stesso arcaico, come in tutti gli esseri umani, e attuale, in quanto il tossicomane ha visto dileguarsi tutti i modelli identificatori che aveva ricercato. Dobbiamo ricordare che per farsi aveva violato la legge nelle sue dimensioni reali, simboliche e immaginarie e che pertanto, come Adamo ed Eva, era stato cacciato dal paradiso.
Nel quadro molto peculiare della cinetica dei fenomeni psichici che il tossicomane vive e interiorizza, si verifica dunque una successione accelerata di investimenti identificatori e immaginari, e quindi la delusione di fronte alla loro insufficienza, che riporta tutto al punto di partenza.
Il problema è che nella logica della dismisura ogni disinvestimento si connota come catastrofe; diventa enorme e vertiginoso, da un lato è il tutto, subito e ora, dall’altro è il nulla e la morte, subito e ora. Non esistono compromessi o mezze misure in quanto tutti i riferimenti che hanno potuto agire in questo o quel momento sono impossibili. Al posto dello specchio infranto ora c’è l’immagine della morte, quella che precede tutto il percepito nel momento dell’incrinatura e quella che chiama quando niente è più possibile. L’uomo qualunque si rassicura dicendo che gli restano venti, trenta o cinque anni da vivere. Al tossicomane non è consentito neppure guardare ai suoi limiti, avendo voluto tutto, subito e ora. Certo quest’angoscia di morte è comune ad altri (e anche, a volte, le protezioni spirituali che si utilizzano), ma in lui essa si materializza in un’immediatezza totalizzante che tutto invade fino al raptus suicida.
Il più delle volte l’overdose non è che l’espressione di questa immediatezza dove tutto è giocato nell’attimo: morire per non ritrovare nulla, vi-vere per scoprire che si esiste.
Così l’angoscia di morte, come tutto ciò che riguarda il tossicomane, è insieme ordinaria e smisurata. Essa è costante e iperinvestita, nell’attimo sembra disprezzata e accantonata dagli aspetti positivi della droga, ma alla fine è lei ad essere vittoriosa, alla distanza e ad ogni caduta del-la sostanza. Al di là del concetto di piacere che il soggetto ha memorizzato, l’oggetto droga ha una funzione anestetica. Quando cessa, ciclicamente o definitivamente, l’effetto narcotico, il tossicomane si ritrova nudo di fronte a ciò che Bataille definisce l”esperienza interiore’ nella quale tutto è nudo e miserabile e l’uomo è ridotto a insetto senza alcun potere sul proprio destino e ciò tanto più crudelmente in quanto egli ha potuto credersi Dio nell’attimo estremo dell’esperienza della droga.
Paradossalmente, più di ogni altro essere al mondo, il tossicomane annulla il tempo vissuto per non morire, ma poiché tutto ciò è artificio, ancora una volta, al di là del piacere, il tossicomane, più di qualunque altro essere al mondo, è sovrainvestito dall’angoscia di morte.
Nel momento in cui si penetra il tossicomane annulla il tutto e nello stesso tempo rende mostruoso il ritorno di questo tutto. La droga permette ogni cosa salvo che di non morire. La trasgressione che il tossicomane si concede si colloca in un tempo che sembra infinitesimale, ma che per lui è enorme. In quel momento la pulsione di morte sembra annullarsi, ma è lì lo scacco del tossicomane in quanto si introducono la mancanza, la mancanza della mancanza e, dunque, la nudità che altro non è se non la morte. Forse Pasolini lo aveva capito, lui che aveva accettato l’inaccettabile, ma guai a chi troppo sfida Eros e Thanatos. Nella sterilità della siringa questa sfida si annulla, con la punizione e nella punizione, perché il soggetto disintossicato, come all’inferno, soffre fino alla fine dei suoi giorni.
Dirlo può apparire scandaloso, ma il tossicomane guarito è un uomo in attesa, in attesa di se stesso, attesa banale, ma attesa la cui intensità e la cui disperazione sono così intense che parlare dell’indicibile piacere dell’angoscia non è più possibile. Questo piacere esiste. E’ temuto e desiderato al tempo stesso perché, come abbiamo detto, si esiste nell’angoscia e attraverso essa, anche se si tratta di uno spazio chiuso, quasi mai nominato, in cui il soggetto è solo con se stesso e che può essere dischiuso solo con il passaggio all’atto.
C’è un piacere, un piacere-angoscia, nel suicidio, nell’aumentare la dose che porta alla morte volontaria, nel misurare la quantità di paura che si esercita sugli altri, l’altro che teme e desidera questo suicidio. Possiamo essere così pessimisti. Così come c’è una spirale ascendente nell’evento tossicomanico è possibile sviluppare una spirale discendente. E’ quando il tossicomane pensa di poter accettare di essere mortale e dunque di non avere tutto, subito e ora, che lentamente potrà, con l’aiuto dei suoi terapeuti e di differenti supporti identificatori, cambiare, essere capace di contenere l’angoscia.